Sui pirati ci sarebbe da scrivere molte cose.
Lasciando perdere
le fandonie degli scribacchini di corte, i pirati, a differenza dei
corsari, andavano per il mare, creavano comunità, libere ed egualitarie,
attaccavano le navi degli stati europei, e il bottino veniva
distribuito egualmente tra i componenti della nave. Non facevano
prigionieri. Spesso quest'ultimi si associavano ai pirati. E quando
sbarcavano in un luogo, non l'occupavano, come si vede nei film da
quattro soldi; venivano ospitati dalla comunità locale, con la quale
intrecciavano rapporti di amicizia e di collaborazione.
Molti dei
pirati, contrariamente al clichè, erano persone curiose e colte.
Bellissima l'introduzione dell'autrice francese al libro " La cucina dei
bucanieri", casa editrice eleuthera-novembre 2003.
Il "tesoro" che
ci hanno lasciato i pirati non sta in fondo al mare, ne' in qualche
isola dei tropici, ma nel cuore di ogni uomo e questo tesoro si chiama
liberta'... liberta' dalla schiavitu' e odio contro i tiranni.
Il figlio di Pandora
______________________________
Non
intendiamo offrire questo storia del capitano Misson, del suo
equipaggio e della loro libera colonia di Libertatia, come un esempio di
Utopia, o come modello per la costruzione di una società líbertaria
oggi. Essa è solo il resoconto di un antico tentativo di realizzare una
comunità genuinamente libertaria ed egualitaria, una comunità che tentò
di vivere secondo i principi di " Libertà, Uguaglianza, Fratenità "
circa cento anni prima della Rivoluzione Francese.

Il
capitano Misson trascorse la maggior parte della propria vita da adulto
come pirata. Ma il suo vascello, che solcava i mari battendo una
bandiera con il motto "Libertà", non era l'unico, tra la fine del 17°
secolo e l'inizio del 18°'. Le navi pirate di quel tempo erano quasi
tutte,vere e proprie repubbliche galleggianti. A bordo, le decisioni
venivano prese dall'equipaggio riunito in assemblea, o da un comitato di
delegati. Alcune navi pirata dei Caraibi si diedero persino dettagliate
costituzioni. Diversamente dai personaggi autoritari di cui si legge
nei racconti di avventure, i veri capi pirata avevano il diritto di
comando solo durante il combattiemento con le navi avversarie; nelle
altre occasioni, era il timoniere a svolgere il ruolo di leader della
cominità, fungendo da arbitro in caso di conflitto tra i mebri
del'equipaggio. Il bottino preso sulle navi catturate veniva diviso in
modo egualitario. Al capitano, di solito, toccava una parte doppia, per
aver fisicamente guidato l'attacco, e in certi casi una volta mezza, o
una volta e un quarto, andava al timoniere, al capo cannoniere e al
carpentiere. Quote fisse venivano anche pagate come indennizzo per le
ferite riportate in battaglia. I capitani spietati e dittatoriali, a
quel tempo, non stavano sulle navi pirate, ma sui vascelli mercantili o
militari. La vita dei marisi "normali" era dura e pericolosa, e la paga
scarsa. Gli ufficilai potevano comminare punizioni che includevano la
catena, la frusta, e il "giro di chiglia": quest'ultima consisteva nel
gettare in mare la vittima, legata a una gomena, e farla passare più
volte (a seconda della gravità del "reato" commesso, sotto lo scafo
della nave. Era una pena che spesso risultava fatale. Il fatto che
presso i pirati non esistesse la ferrea disciplina che regnava sulle
altre navi, viene spesso addotto come una delle cause della loro
sconfitta. Ma questa è una strana asserzione, poiché i pirati
effettivamente sconfitti furono assai pochi: sulle rotte delle Indie
orientali, le probabilità di cattura erano meno dell'uno per cento, e su
quelle delle Indie occidentali erano praticamente nulle.
L'unica
fonte per una storia completa di Misson e del suo equipaggio è la
"Storia generale delle scorrerie e dei delitti dei pirati più famosi",
scritta dal capitano Charles Johnson. La storia di Misson appare nella
seconda edizione ampliata di quest'opera, pubblicata nel 1726.
Sfortunatamente, essa è l'unica fonte di informazioni su Misson. Di
alcuni pirati citati nella "Storia generale" si parla anche in altri
documenti bibliografici, ma non di Misson. A causa di tale mancanza di
informazioni sicure, diversi autori negano credito al resoconto di
Johnson, come se fosse solo il frutto d'invenzione. Esiste anche chi
avanza il sospetto che Charlse Johnson non fosse che uno pseudonimo di
Daniel Defoe. Nonostante ciò, comunque, c'è da chiedersi perchè mai, in
un catalago esauriente ed autorevole, come la "Storia generale", Johnson
avrebbe scelto di includere proprio un personaggio inventato. Non
bisogna dimenticare, inoltre, che Johnson scriveva d'avvenimenti molto
recenti, riguardanti, in certi casi, persone ancora viventi, le cui
imprese vere o presunte potevano essere note ai lettori. Qualche
riferimento a Misson, in particolare in relazione alla sua amicizia col
pirata americano Tew, è reperibile solo su testi posteriori alla "Storia
generale" di Johnson. E' possible che Johnson abbia usato Misson, vero o
immaginario che fosse, come veicolo per le sue idee progressiste. Il
discorso contro i profittatori della schiavitù, ad esempio, sarebbe
stato certamente meno pericoloso se riportato come pronunciato da un
pirata, che non scritto in prima persona, tenuto presente che anche la
Famiglia Reale aveva un vasto interesse finanziario nella tratta degli
schiavi. Johnson stesso dichiarava che il nocciolo della storia
proveniva da un manoscritto attributo a Misson medesimo, passato a
Johnson da un suo contatto francese; quand'an che ciò fosse vero, però,
Johnson non sarebbe stato nè il primo nè l'ultimo storico ad essere
incappato in un documento falso. Eppure, leggendo la "Storia generale",
Johnson non appare come un ingenuo. A quei tempi, un altro pirata della
tradizione popolare era Avery, del quale si diceva che avesse come un re
in un'isola del paradiso, piena di tesori e di fanciulle indigine a
disposizione. Johnson lo stanò e risultò che era un ubriacone bugiardo e
senza un soldo. Allo stesso modo che ad altri eroi popolari, come Robin
Hood, anche a Misson sono state accreditate, oltre alle sue imprese,
anche quella degli altri, o imprese esagerate o fantastiche. E come
nella storia di Robin Hood, anche in quella di Misson sono
riconoscibili, al di là dei fatti, le tracce di desideri, di speranze,
ed è appunto questo a renderla degna d'interesse; la storia di Misson è
un tributo di 250 anni fa all'ideale di una società basata alla
cooperazione e sul mutuo appoggio, una società che si prendeva cura
degli anziani e degli inabili, era magnanima con i malfattori, e
svolgeva le proprie attività senza bisogno di denaro o di polizziotti.
Misson (un nom de guerre, quello vero è sconosciuto) nacque in Provenza
da ricca e rispettata famiglia. Studiò lettere, logica e matematica, e
frequentò per un anno l'Accademia di Angers. Al suo ritorno, a sedici
anni, avrebbe voltuo arruolarsi nei Moschettieri, ma il giovane Misson
era un appassionato lettore di racconti di viaggi e desiderava viaggiare
egli stesso. Così, sfruttando il fatto che un suo parente, il signor di
Fourbin, era capitano su di nave militare, la Vicotirie, riuscì a farsi
assegnare ad essa come volontario e partì alla volta di Marsiglia per
raggiungerla. Ben presto la Vicotire salpò, facendo rotta per il
Mediterraneo e Misson si dedicò con entusiamsmo al suo lavoro. Nel tempo
libero pagava il nostromo e il carpentiere perchè gli insegnassero i
segreti della costruzione e della manutenzione delle navi. Quando la
Victorie attraccò a Napoli, Misson ottenne il permesso di recarsi in
visita a Roma, un suo particolare desiderio. Restò disgustato dalla
decadenza della corte papale e giunse alla conclusione che "la religione
serviva solo a tenere sotto controllo la mente dei più deboli".
Confessò i suoi dubbi ad un giovane prete domenicano, il quale, con sua
grande sorpresa, si dichiarò:" Per quanto mi riguarda, sono stanco di
questa farsa, alla prima occasione intendo liberarmi di quest'abito da
carnevale". Misson fornì l'occasione, acquistando per lui dei vestiti e
conducendolo a bordo della Victoire come volontario. Il prete si
chiamava Caraccioli, ed i due sarebbero restati amici per tutta la vita.
Raggiunsero la nave a Livorno. Un paio di giorni dopo aver salpato,
furono attaccati da due vascelli di pirati Salee. La Victoire ne affondò
uno e arrembò l'altro. Misson e Caraccioli parteciparono all'assalto in
prima fila, e l'ex prete, in seguito a ciò, venne colpito alla coscia e
dovette essere operato.
" Un arrembaggio non è uno scherzo,
ragazzo. Tu stai lì con gli altri, sul ponte, e vedi l'altra nave che si
avvicina . . . piano piano . . . sempre più vicina ... E ti senti
morire ... "Le parole del vecchio timoniere gli tornavano alla mente,
ora. Il vascello pirata aveva ridotto la velatura e manovrava per
affiancare, mentre la Victoire faceva lo stesso. Gli ufficiali giravano
in mezzo agli uomini, dando ordini secchi e consigli. Si capiva che
anche loro avevano paura. Voi coi moschetti, più sottò. Controlla
l'innesco di quella pistola, marinaio ... " Certe volte te ne stai lì
anche un'ora, e più, ad aspettare che venga il momento. E intanto quelli
sparano cannonate, e il bersaglio sei tu, ragazzo. Quelli sparano e tu
non puoi far niente ... senti le palle che arrivano fischiando e puoi
solo sperare che prendano qualcun altro, non te...
Ora si
vedevano le lacce dei pirati. Le barbe, i fazzoletti annodati sul capo.
Un tipo impennacchiato come un moschettiere stava ritto sulla murata,
tenendosi ad una scotta. Doveva essere il capo di combattimento, quello
che guidava l'assalto. Erano tanto vicini che Misson potè distinguere
gli occhi sbarrati, le labbra strette. Gli ufficiali continuavano a
parlare.
- Attenti, uomini! Ci siamo... " Ma il più brutto è
quando devi saltare dall'altra parte, ragazzo. Improvvisamente ti sembra
di essere solo, ti sembra che nessuno stia saltando con te, e ti dici:
cristo, ma solo io devo andare di là a farmi ammazzare? E poi senti
qualcuno che ti grida nelle orecchie: arremba, filone, figlio di
puttana, arremba, cosa aspetti... e magari ti arriva una pedata nel
culo, o una frustata. E allora salti... "
Poco prima che le due
navi venissero a contatto, da entrambe le parti cominciarono a volare
grappi di varia loggia, per assicurare l'abbordaggio, mentre qualcuno
non riusciva a trattenere l'emozione e scaricava le armi verso gli
avversari. Accanto a Misson, Caraccioli farfugliava tra i denti, forse
una preghiera o forse una litania di bestemmie partenopee. Poi gli
ufficiali cominciarono ad urlare come forsennati e la ciurma si mosse.
Misson pose un piede sulla murata, prese lo slancio e saltò...
Tornata
a Marsiglia, un mese dopo la Victoire venne inviata a La Rochelle, da
dove avrebbe dovuto scortare alcuni mercantili in rotta per le Indie
occidentali. Ma questi non erano ancora pronti, e Misson e Caraccioli
s'imbarcarono sulla Corsara Triunph, per una breve scorribanda nella
Manica. Predando i mercantili inglesi, radunarono un cospicuo bottino
che vendettero a Brest. I nostri due amici rientrarono sulla Victoire e
qualche settimana più tardi fecero vela per le isole di Martinica e
Gudalupa. Il lungo viaggio offrì loro molto tempo per discutere.
Ritenendo ormai smascherata la chiesa cristiana, Caraccioli volse la sua
attenzione verso le assurdità della relgione ebraica e musulmana. Anche
altri membri dell'equipaggio presero ad unirsi alle discussioni, e ben
presto Caraccioli si trovò ad avere un seguito di proseliti, che
vedevano in lui una specie di nuovo profeta insorto a combattere gi
abusi della religione. Ma Caraccioli era appena all'inizio : " (...)
quando ebbe sperimentato gli effetti della sua polemica antireligiosa,si
rivolse contro i governi, e mostrò allora come ogni uomo sia nato
libero e abbia diritto al proprio sostentamento al pari dell'aria che
respira (...) e come le grandi disparità tra uomo e uomo, alcuni viventi
nel lusso e altri nell'indegenza più totale, siano esse dovute soltanto
all'avarizia e all'ambizione di una parte e alla pusillamine
acquiescenza dell'altra". Caraccioli si pronunciò contro la pena di
morte e dichiarò che bisognava rinunciare al diritto di uccidere,
eccetto che "in difesa del nostro diritto materiale, cioè il diritto a
godere di quanto è necessario per il nostro sostentamento". Quindi parlò
a Misson dell'idea di "mettermi per conto proprio", un'idea che andava a
genio anche a molti dell'equipaggio.
Matthieu Le Tond faceva il
timoniere da quasi vent'anni, ed era in mare da sempre. Aveva visto,
come egli stesso diceva, tutto quanto un uomo può vedere e ben più di
ciò che può sopportare. Questo lo aveva fornito, col passare del tempo,
di un pessimo carattere, nonchè della convinzione che fosse suo dovere
farlo apparire, se possibile, anche peggiore. Viveva dunque eternamente
preoccupato che qualcuno potesse farsi di lui l'idea di un vecchio mite e
bonario (il che, peraltro, assai difficilmente avrebbe potuto
verificarsi) e si proteggeva da una simile eventualità coprendo di
sanguinose contumelie tutti coloro che gli rivolgevano la parola, con un
turpiloquio ricco e fantasioso come un esercizio di retorica. La vita
di mare con le sue asprezze, gli forniva frequenti occasioni di
esibizione e ciò lo teneva tranquillo, per così dire. Ma quando Misson e
Caraccioli cominciarono a rendere pubbliche le proprie discussioni, e a
coinvolgere in esse l'equipaggio, si trovò ben presto in grande
imbarazzo. Il suo "stile" gli avrebbe imposto di mandare pittorescamente
al diavolo quei due giovanotti che parlavano in modo forbito ed
elegante, in particolare quell'italiano con la sua ridicola pronuncia.
Eppure, quello che dicevano gli sembrava giusto, e non poteva
trattenersi dal trovarsi d'accordo con loro e ammirare come sapevano
ribattere alle contestazioni e chiudere la bocca anche agli ufficiali,
quelle rare volte che intervenivano. E avrebbe voluto dar loro manforte,
specie quando parlavano male dei preti, di cui ricordava ancora le
botte che gli davano all'orfanotrofio. Ma non poteva tradire il suo
"stile", e quindi si limitava a tacere. Era un silenzio, sofferto e
contrastato, però. E la sera, quando in qualche angolo della coperta si
formava il solito crocchio, e la discussione pian piano prendeva
l'avvio, cogliendo spunto da una riflessione, o da un commento al fatto
della giornata, e subito si animava mentre il commento andava
allargandosi in considerazioni più generati ed impegnative, e i nomi
fatidici (libertà, uguaglianza, governo . . .) cominciavano ad es-sere
pronunciati, si poteva vedere la sua ombra solitaria sedere in disparte,
là dove credeva di non essere notato, ad ascoltare, grugnendo fra sè e
sè...
Incrociando al largo della Martinica, la Victoire intercettò
una cannoniera inglese da quaranta pezzi, la Winchelsea.Le navi vennero
a battaglia,e alla prima bordata del vascello britannico, il capitano,
il secondo e i tre luogotenenti della Victoire restarono uccisi. Il
timoniere, unico rimasto dello staff di comando, avrebbe voluto
arrendersi, ma Misson e Caraccioli riorganizzarono l'equipaggio e per
tre ore continuarono il combattimento. Improvvisamente, per qualche
sconosciuto motivo, a bordo della Winchelsea ci fu una tremenda
esplosione, e la nave in pochi minuti affondò. Dalla Victoire vennero
calate alcune scialuppe, ma si recuperò un unico sopravvissuto, il
luogotenente Franklin, che morì due giorni dopo per le ferite riportate.
L'equipaggio della Victoire si trovò, di colpo, ad avere in mano il
controllo della nave. Caraccioli parlò agli uomini, evocando gli inizi
della fortuna di Maometto e di Dario, ma non c'era bisogno della sua
capacità persuasiva perché tutti si rendessero conto della potenzialità
di quella situazione. Misson annunciò la sua intenzione di condurre una
vita di libertà, e molti dell'equipaggio lo invitarono ad eccettare il
ruolo di capitano. Egli si disse d'accordo, a patto che coloro che non
intendevano seguire il suo destino fossero sbarcati in qualche località
civilizzata. Nessuno volle avvalersi di questa possibilità. Venne quindi
eletto un "consiglio di vascello", formato da Caraccioli in qualità di
luogotenente, dal mastro d'istruzione come secondo e da Jean Besace come
terzo. Il timoniere Matthieu Le Tondu e il capo-cannoniere vennero
nominati rappresentanti dell'equipaggio in seno al consiglio. Il nuovo
consiglio si riunì subito nel quadrato, per decidere la rotta da
seguire. Tutti furono d'accordo che la costa spagnola era con tutta
probabilità la direzione più conveniente. Mattieu Le Tondu pose il
problema della scelta della bandiera e ne suggerì una nera come la più
terrificante. Ma Caraccioli obbiettò: essi non erano pirati, ma vigili
guardiani dei diritti e delle libertà popolari, quindi una bandiera
bianca con la parola "Libertà " nel centro sarebbe stata assai più
adatta. Il consiglio accettò. Il tendone dei quadrato era stato
arrotolato, in modo da permetere all'equipaggio di ascoltare lo
svolgersi della riunione. A questo punto, i marinai levarono tutti
insieme il grido: "Libertà!". Le proprietà degli ufficiali deceduti
vennero portate sul ponte. Chi aveva bisogno di vestiti ne ebbe di
nuovi, e il denaro fu posto in un forziere comune, ben chiuso con un
lucchetto di cui ogni membro del consiglio aveva la chiave. Misson prese
dal quadrato tutta l'argenteria della mensa ufficiali e la depose nel
forziere, ma l'equipaggio insistette che la tenesse per uso proprio.
Egli si rivolse allora alla comunità della nave e la invitò, in nome
dell'amore fraterno a "bandire tutte le liti personali e i malcontenti.
Stavano liberandosi dal giogo della tirannia ... ed egli sperava che
nessuno avrebbe seguito l'esempio dei tiranni, e avrebbe volto le spalle
alla giustizia; perchè quando la giustizia viene calpestata, la
miseria, la confusione e la sfiducia a reciproca seguono naturalmente".
Misson avvertì i marinai che avrebbero trovato ben pochi amici nel
mondo. Disse che la maggioranza degli suoi viveva in schiavitù, e da ciò
la loro volontà "era spezzata", rendendoli incapaci di pensieri
generosi. "Essi danzano alla musica delle loro catene, e darebbero a
questo prode equipaggio l'infame appellativo di pirati, e riterrebbero
meritorio partecipare alla sua distruzione". La ciurma della Victoire
contava duecento braccia abili e trentacinque uomini malati o feriti. Al
largo di S. Cristoforo catturarono una corvetta inglese: da essa
presero due barilotti di rhum e sei sacchi di zucchero,quindi la
lasciarono andare. Il capitano della corvetta, Thomas Butler, riconobbe
di non aver mai incontrato, prima d'allora, un nemico così onesto.

Dopo
alcune avventure di minor conto, tra cui il tentativo, fallito, di una
nave corsara di prendere la Victoire, i pirati della libertà riuscirono a
catturare un vascello olandese. Giunti a Cartagena, Misson e Caraccioli
si travestirono da ufficiali della marina francese, presentandosi come
Fourbin e il suo primo ufficiale, e poterono vendere il bottino e
sbarcare i prigionieri. Il governatore, tal Don Giovanni de La Zerda,
restò così favorevolmente impressionato dai due, che, conclusi gli
affari, chiese loro un piccolo favore: avrebbe gradito che la Victoire
si recasse a Porto Bello per scortare il St. Joseph, un galeone da
settanta cannoni, lì ancorato. L'ingenuo funzionario era preoccupato per
l'incolumita' del suo carico, che consisteva in 800.000 pezzi da otto e
un cospicuo quantitativo di oro in lingotti.
La Victoire partì
per prendere contatto con il St. Joseph, ma giunse a Porto Bello che
questo aveva già salpato da due giorni. Lo scafo della Victoire era
incrostato e ciò rallentava l'andatura e rendeva difficile tenere la
rotta. Le tiepide acque dei Caraibi, infatti, favorivano la crescita di
alghe sulla parte immersa delle navi, nonchè di molluschi come il
"taredo", che si attaccano allo scafo corrodendo il legno. Per tali
ragioni, le navi dovevano essere ricarenate da tre a sei volte all'anno,
il che implicava tirare in secco le imbarcazioni, raschiare lo scafo e
sostituire le parti danneggiate del fasciame. Le navi migliori avevano
lo scafo ricoperto di piombo, o rame, ma i pirati dovevano accontentarsi
di calafatare la carena con una miscela di catrame, sego e zolfo. Non
avendo accesso a bacini di carenaggio, i pirati usavano tirare a riva le
navi, e le inclinavano prima su un fianco, poi sull'altro, per mezzo di
gomene assicurate agli alberi vicini. A volte riuscivano a fare
soltanto un carenaggio parziale, quando erano di fretta.
Nelle
condizioni in cui era, la Victoire aveva scarse probabilità di
intercettare il St. Joseph, così i pirati abbandonarono la caccia e si
diressero verso una baia chiusa. Qui, spostando i cannoni
alternativamente dall'uno e dall'altro lato della nave, riuscirono ad
inclinarla in modo da esporre la maggior parte dello scafo, raschiandolo
e catramandolo meglio che potevano, ma senza che fosse possibile, però,
eseguire un carenaggio completo della chiglia.
Il vascello era
ora in grado di riprendere il mare, e il consiglio si riunì per decidere
la rotta da seguire. Misson e Caraccioli insistevano per dirigere verso
la costa africana, mentre gli altri erano per il New England,
sostenendo che la Victoire non poteva comunque affrontare una traversata
atlantica. Poichè il consiglio non riusciva ad esprimere un parere
unanime, fu indetta un'assemblea generale dell'intera comunità della
nave: la scelta fu per l'Africa. Dopo una traversata senza
inconvenienti, in prossimità della Costa D'oro i pirati si imbatterono
nel Nieuwstadt, un vascello schiavista di nazionalità olandese. Lo
presero dopo una battaglia di due ore e mezzo. La nave aveva appena
incominciato la tratta, e aveva a bordo soltanto diciassette schiavi.
Misson li fece liberare dalle catene e diede loro dei vestiti presi
dall'equipaggiamento degli olandesi. Quindi proclamò all'equipaggio che
"nessun uomo aveva potere sulla libertà altrui, e il fatto che coloro
che vantavano una più illuminata conoscenza della divinità vendevano gli
uomini al pari delle bestie, provava che la loro religione ero solo un
inganno ipocrita ". Dal canto suo, "egli non aveva sottratto il suo
collo al giogo della schiavitù e reclamato la sua libertà, per poi
rendere schiavi altri uomini". Ogni ex-schiavo venne affidato ad un
gruppo di marinai della Victoire, in modo da rendere più agevole
l'apprendimento della lingua e delle attività necessarie alla conduzione
della nave. Lo scopo, evidentemente, era di favorire l'inserimento dei
nuovi venuti in seno all'equipaggio. Dopo la traversata dell'Atlantico,
la Victoire era nuovamente in pessima stato: "Essa era sempre più
incrostata di alghe e conchiglie, e navigava quindi con difficoltà,
sicchè i pirati risalirono per un tratto il fiume Lagos, e quivi la
tirarono in secco, onde sostituire con legname nuovo le parti più
malandate del fasciame e carenare lo scafo". Poi carenarono anche il
vascello olandese e si diressero a sud. Durante il viaggio, Misson, si
trovò costretto a riunire l'assemblea della nave per tenere
all'equipaggio un discorso sul turpiloquio e l'ubriachezza. Gli olandesi
prigionieri stavano trasmettendo cattive abitudini ai francesi, e ciò
aveva ripercussioni sul morale generale. Al largo dell'Angola, i pirati
presero un'altra imbarcazione olandese, che portava un carico di
tessuti. Con esso, i velai della Victoire poterono rivestire
decentemente gli uomini, poichè "tutto l'equipaggio aveva ormai gli
abiti a brandelli. In totale, Misson aveva ora novanta prigionieri, che
lasciò sul Nieuwstadt con viveri sufficienti per raggiungere un
insediamento olandese lungo la costa. Undici olandesi scelsero di
rimanere sulla Victoire. A nord di Table Bay la Victoire venne attaccata
da una cannoniera inglese della sua stessa classe (quaranta pezzi). Con
un'audace manovra, Misson l'abbordò e la prese.
- Le andiamo
incontro sul filo del vento !- disse il veccbio timoniere con strana
esultanza. - Signor Le Tondu, siete pazzo! - ribattè Misson - La
Victoire non può andare di bolina come un catter. Ce la metteremo per
cappello ... Per cappello ci metteremo i vostri coglioni di menagramo,
signor Misson! Preparate gli uomini per l'arrembaggio e non venite ad
insegnarmi come si fa a navigare!
Piccato, Misson tacque, mentre
il timoniere dava mano alla barra. La prua continuò a spostarsi,
cercando la rotta, e in un attimo il vento aveva riempito le vele con
tutta la sua gagliardia. La Victoire si inclinò di lato per rovesciarsi,
tanto che il mare parve sul punto di ottrepassare la murata di
sottovento per venire in coperta a inghiottire l'equipaggio nelle sue
liquide fauci. Ma la nave prese a filare sulle onde, e sembrava un
enorme castello incantato spinto dalla magia di mille demoni, che
gemevano straziati dal fasciame in tensione, stridevano dalle sartie,
ululavano, prigionieri nel ventre gonfio delle vele. E sopra quelli
inferno di suoni laceranti si levò la voce di Le Tondu, aspra e tonante
insieme, a rassicurare gli uomini ammutoliti con orgoglio della propria
abilità di navigatore:
- Non temete marinai, figli di uno squalo!
Fidatevi dei vostro nocchiero che vi porta a spasso per il mare!
Mezz'ora quasi, durò la lotta bolina della Victoire. Il vascello inglese
tentò un traverso per sottrarsi all'appuntamento con i pirati, ma
questi viaggiavano a velocità quasi doppia, e gli furono addosso quando
non aveva allargato nemmeno di un miglio. Poco prima di giungere a tiro
dei cannoni, Matthieu Le Tondu virò, puntando dritto contro gli
avversati, prua contro prua, in rotta di collisione. In quel modo,
nessuna delle due navi poteva, sparare: il timoniere stava evitando uno
scontro a fuoco e manovrava per l'arrembaggio. All'ultimo momento, Le
Tondu virò di nuovo. La prua della Victoire si spostò, evitò quella
della nave inglese, strisciò contro il bordo di questa, affiancandola e
frenandola col proprio slancio. - Io ho fatto la mia parte, Misson! Ora
tocca a te, ragazzo! Misson stava ritto sulla murata in equilibrio tra
le sartie, una pistola in una mano, una sciabola da carpentiere
nell'altra. - All'arrembaggio! - Mentre saltava, sentì l'urto degli
uomini che lo seguivano...
Quasi tutti i marinai inglesi, tranne
gli ufficiali, passarono dalla sua parte. Caraccioli fu posto a capo del
vascello catturato, ribattezzatò Bijoux, e la ciurma elesse i suoi
ufficiali. In seguito, le due navi fecero vela per l'isola di Johanna, a
nord del Madagascar. Questa era un approdo comune per le imbarcazioni
che e facevano rotta per le Indie, grazie alla possibilità di ricchi
rifornimenti d'acqua potabile e frutta anti scorbuto, nonché della
natura amichevole dei nativi. I pirati stabilirono buone relazioni con
gli indigeni e li aiutarono a difendere l'isola da un tentativo di
invasasione da parte dei vicini dell'isola Mobilian. Durante la loro
permanenza, molti dei marinai, compresi Misson e Caraccioli, scelsero
una compagna tra le fanciulle del posto, delle quali, dopo tanti mesi di
navigazione, non si poteva fare a meno di apprezzare la bellezza e la
spontaneità.
Le ragazze danzavano languide, alla luce rosseggiante
dei falò. Sorridenti ed esplicite, e pur candide, ammiccavano agli
uomini senza vergogna, tendendo loro le mani, ancheggiando invitanti di
fronte ai più timidi. Anche i maschi, i padri, i fratelli, ridevano:
osservavano divertiti l'intrecciarsi delle schermaglie, commentavano con
grandi sghignazzi l'intraprendenza delle loro donne e il comico
imbarazzo dei bianchi, si davano di gomito additando le coppie che
andavano a concludere la festa nel fitto della boscaglia.
Dov'erano
finiti, i tristi amori dei marinai a terra? I vicoli puzzolenti degli
angiporti, i rapidi amplessi al piano superiore di infami taverne, con i
compagni ubriachi che aspettavano il loro turno fuori della porta?
Dov'era l'alito pesante delle meretrici, la frustante passività di
quelle carni sfatte, di quelgi occhi assenti, di quelle dita strette
sulla moneta appena consegnata? E i ruffiani con i loro randelli, pronti
a intervenire se ti attardavi oltre la tariffa, dov'erano andati? Tutto
sparito, tutto dimenticato. L'abbiezione, lo squallore, la violenza dei
congressi carnali offerti dalla "civiltà", sembravano, ed erano,
lontani centinaia di miglia. Unica traccia di essi, non restava che
l'attonito stupore con cui gli uomini con cui gli uomini accoglievano
ora l'ebrezza purificatrice di quella pagana sensualità, la felice
meraviglia di fronte a quel donarsi gratuito e spontaneo, di fronte alla
bellezza e alla gioia che per la prima volta vedevano far corona
all'amore. E questo temperava la foia, che in altre occasioni sarebbe
scoppiata selvaggia, condita dall'astinenza e dalle privazioni della
vita sul mare, e dava loro una sorta di scontrosa gentilezza che
esaltava le fanciulle indigene.
Matthieu Le Tondu, dopo una
resistenza di circostanza, accettò la corte di una bruna bellezza che
seppe conquistarlo accarezzandogli maliziosamente la pelata. Si alzò, e
prese parte alle danze fra gli applausi dei compagni. Un vecchio
indigeno sdentato, quasi un suo sosia malgascio, lo apostrofò con gesti
che alludevano evidentemente alla qualità delle prestazioni che l'età
gli consentiva. Il vecchio navigatore stava per rispondere come suo
solito, con qualche sequenza di sconcezze, ma la ragazza scoppiò in una
risata squillante, lo prese per mano e, prima che potesse profferir
parola, lo trascinò via, tra gli alberi ...
Usando Johanna come
base, Misson corse la zona in cerca di prede. Intercettò un battello
portoghese, e, nonostante fosse la metà della Victoire, fu necessario un
lungo e sanguinoso combattimento, prima di poterlo prendere. Portava un
carico di polvere d'oro pari ad un valore di un quarto di milione di
sterline. Un ricco bottino, che costò però un alto prezzo in vite umane:
trenta morti e ventisette feriti, compreso Caraccioli, al quale si
dovette amputare la gamba destra. Mentre Caraccioli stava a Johanna a
rimettersi dalle ferite, Misson salpò nuovamente con la Victoire.
Diresse verso il Madagascar, e costeggiò quest'isola da sud a nord, fino
alla punta estrema di essa, quindi volse indietro la prua. A nord di
Diego Suarez, scoprì una baia, e all'interno di essa individuò un porto
ampio e sicuro, con acqua potabile in abbondanza. Gettata l'ancora,
sbarcò e poté constatare che "la terra era buona, l'aria salubre, e la
zona pianeggiante". Disse ai suoi uomini che quello era un luogo
eccellente per un rifugio e che era sua intenzione costruirvi una
piccola città fortificata, con docks per le navi, dove dove essi
avrebbero potuto trovare asilo qunado l'eta' e le ferite li avessero
resi inabili ad andare per mare,un posto tutto per loro dove avrebbero
potuto godere i frutti della loro fatica e aspettare la morte
serennamente.

Ritornato
a Johanna, Misson espose il suo piano agli equipaggi delle due navi e
ottenne la loro approvazione. Inoltre, la regina dell'isola, in cambio
della promessa di venire in soccorso a Johanna in caso di attacco, gli
offrì trecento uomini per aiutarlo a costruire la nuova base. L'unica
condizione posta era che gli uomini tornassero a Johanna entro quattro
mesi. l pirati chiamarono la loro nuova patria Libertatia, e a se stessi
diedero l'appellativo di Liberi, rinunciando a definirsi Inglesi,
Francesi, Olandesi o Africani. Per prima cosa, costruirono due forti,
uno per ogni lato dei porto. Questi erano armati con quaranta cannoni,
presi alla nave portoghese. Poi si diedero a costruire case e magazzini.
Un gruppo andò in missione nell'interno, per stringere rapporti
amichevoli con i nativi e scambiare doni. Quando i lavori erano ormai
avviati, Misson spinse la Victoire fino alla costa di Zanzibar e
intercettò un'altra nave portoghese che portava un carico d'oro. La
Victoire viaggiava con armamento ed equipaggio ridotti, cosicché Misson,
comprendendo di aver addentato un boccone troppo grosso, tentò di
sganciarsi. Ma il vascello portoghese insegui la Victoire e attaccò
battaglia. Lo scontro durò quattro ore: alla fine, i pirati riuscirono
ad abbordare la nave e a prenderla. I marinai portoghesi vennero
rinchiusi sottocoperta e, con l' indispensabile di equipaggio, la preda
seguì la Victoire a Libertatia. In vista del Madagascar, incrociarono
una corvetta che inalberava una bandiera nera su cui era dipinto, in
bianco, un braccio che brandiva una scimitarra. Era il veliero del
pirata Thomas Tew. Le due navi si affiancarono, e i francesi si recarono
in visita a conoscere i "colleghi" americani. Dopo qualche discussione,
Tew e i suoi uomini decisero di accompagnare la Victoire a Libertatia.
Tew
sembrava uscito da un racconto d'osteria. Portava un cappello a tesa
larga, ornato con penne d'albatros e di pappagallo, piantato alla brava
su di una massa di riccioli che avevano raramente conosciuto il sapone.
Addosso aveva un giustacuore di marocchina ricamata, con una fusciacca
rossa alla vita, tanto alta e stretta da sembrare una specie di busto
femminile, e sotto un paio di brache da gran signore, di seta rilucente,
tutte sbuffi e pizzi, frutto evidentemente di qualcbe recentissima
ruberia, perchè apparivano nuove come appena uscite dalla bottega del
sarto. Era armato fino ai denti. Oltre a due mazzagatti infilati nella
fascia, ben quattro pistole di notevoli proporzioni gli pendevano dalla
cintura, appese per la dragona, e al collo teneva una vera collezione di
fiaschette da innesco, cariche predosate, loading blocks all'uso
americano e altre piriche attrezzature.
Parlava forte, con
frequenti risate e grandi pacche sulle spalle dell'interlocutore. A
Misson, all'inizio, non piacque. Gli sembrava la rappresentazione di ciò
che lui non voleva essere, il pirata tipico così come lo dipingono i
capitani in pensione nei loro resoconti, quello che a sentirlo
descrivere viene voglia di impiccarlo all'albero di maestra. E Tew, con
la sua ostentata tracotanza, col suo repertorio di inutili millanterie
(" Puoi contarci, uomo! ", " So quel che dico, fratello! " ... )
suscitava a volte desideri di quel genere. Ma i suoi uomini lo
trattavano con affettuosa condiscendenza, e di tanto in tanto lo
motteggiavano, ed egli faceva lo stesso nei loro confronti, con
cameratesca familiarità, più che una banda di pirati, quell'equipaggio
sembrava la brigata di amici reduci da una via crucis per le taverne.
Eppure tutti portavano sulle carni i segni di aspre battaglie. Tew
stesso recava una ferita ancor fresca sul braccio, rabberciata alla
meglio con una pezza. Misson cominciò a pensare che, sotto
quell'improbabile costume variopinto, poteva esserci un buon compagno.
Disse Caracciolí: "Sti americani... sonò nu poco strunzi, ma sò
guaglioni 'e core . . .
L'ideale di una libera colonia come quella
che Misson stava costruendo, non era nuovo per questi pirati. Poco
tempo prima, dall'equipaggio di Tew si era staccato un nucleo di
ventitrè uomini, compreso il timoniere, che erano andati, anch'essi ad
impiantare una loro comunità sulla costa malgascia, non distante da
Libertatia.
Quando la piccola flotta giunse in porto, Tew sparò
una salva di nove colpi di cannone, come saluto, e il primo forte
rispose allo stesso modo. Il loro arrivò però, poneva a Libertatia un
problema. Essi avevano adesso centonovanta prigionieri portoghesi, di
fronte a una popolazione della comunità di soli duecento uomini, a parte
gli isolani di Johanna. Circa settanta dei prigionieri portoghesi si
unirono ai Liberi, dopo un discorso di Caraccioli (che Johnson descrive
come un uomo che aveva "l'arte della persuasione"). Il resto venne
adibito alla costruzione di un nuovo dock, mezzo miglio sotto
l'imboccatura del porto. Essi erano tenuti isolati in quell'area, e
Libertatia non aveva comunicazione con loro, come precauzione nel caso
si fossero resi conto della forza del proprio numero e si fossero
ribellati. Tra le due comunità stava il Bijoux, di sentinella.
Col
passare del tempo i pirati divennero agricoltori, seminando mais, grano
ed altre piante di cui avevano trovato le sementi a bordo dei vascelli
catturati. I campi erano coltivati in comune e "non c'erano recinti di
alcun genere a segnare le proprietà di ciascuno". Venne il momento che
gli uomini di Johanna dovettero tornare alla propria isola, secondo gli
accordi. Ciò poneva un nuovo problema: mandar fuori una nave con
equipaggio ridotto significava rischiare di perderla, e, d'altro canto,
equipaggiarla completamente significava sguarnire Libertatia e rischiare
che i prigionieri portoghesi si prendessero la città. Misson propose di
consegnare l'ultimo vascello catturato ai prigionieri, e lasciarli
liberi. Tew e Caraccioli si opposero, sostenendo che in tal modo
l'esistenza della loro base sarebbe divenuta ben presto di dominio
pubblico, e sarebbero stati attaccati. Come al solito, venne indetta
un'assemblea per decidere: venne accettata la proposta di Misson, non
essendovi altra alternativa se non massacrare tutti i prigionieri.
Misson parlò a costoro, dicendo che si rendeva conto che dare loro la
libertà avrebbe avuto come conseguenza l'aggressione di Libertatia, non
appena la sua ubicazione fosse stata resa nota. Ma, aggiunse, "egli non
faceva guerra agli oppressi, bensì agli oppressori". Si interessò dei
problemi di ciascuno e, nei limiti del possibile, fornì loro aiuto. In
cambio, chiese che ognuno giurasse solennemente che non si sarebbe mai
arruolato per combattere contro Libertatia. La nave, privata dei
cannoni, fu approvvigionata per un viaggio fino alla costa di Zanzibar, e
partì. Qualche giorno dopo, giunse in visita una cinquantina di
indigeni delle tribù locali, per commerciare bestiame e schiavi. Vennero
intavolate trattative e gli schiavi che poterono essere affrancati
"furono immediatamente forniti di abiti e posti sotto la protezione dei
bianchi che, con ogni dimostrazione possibile, si sforzarono di far loro
comprendere quanto fossero avversi ad ogni forma di schiavitù".
Risolto
il problema dei prigionieri portoghesi, il Biioux poté riportare a casa
gli uomini di Johanna. Ci vollero tre viaggi, per completare
l'operazione. Alcuni membri dell'equipaggio di Misson, che erano rimasti
colà, approfittarono dell'ultimo viaggio per trasferirsi a Libertatia
con le proprie donne e bambini. Dopo il loro ritorno, Misson e
Ceraccioli si diedero da fare per portate a termine la costruzione dei
docks, mentre Tew partiva col Bíjoux per un raid alla volta della costa
della Guinea.
Subito a nord dei Capo di Buona Speranza, Tew prese
una galea delle Indie occidentali olandesi e trovò, a bordo una grande
quantità di corone inglesi. Queste furono "destinate al tesoro comune,
poiché a Libertatia di nessun servizio era il denaro, ogni cosa essendo
in comune". Al largo della costa dell'Angola, poi, venne catturata, una
nave schiavista, con duecentoquaranta tra uomini, donne e bambini,
rinchiusi sottocoperta. I marinai africani del Bijoux, che a suo tempo
erano anch'essi stati fatti schiavi su quella costa, scoprirono fra essi
molti parenti ed amici. Dando a Tew ampie garanzie della loro buona
condotta, gli africani liberarono i prigionieri dalle catene e li
accolsero a condividere le glorie della loro nuova vita.
A
Libertatia, dopo il completamento del nuovo dock, venne iniziata la
costruzione di due corvette da ottanta tonnellate, armate ciascuna con
otto cannoni, che vennero battezzate rispettivamente Gioventù e Libertà.
Dovevano servire per una spedizione incaricata di compilare una carta
nautica dell'isola del Madagascar, con l'indicazione delle coste, dei
lidi, delle secche e delle fosse, nonché come naviscuola per
l'addestramento degli schiavi liberati.
I tentativi di insegnare
agli africani un pò di francese, finirono per produrre una specie di
utile esperanto, una sorta di lingua-franca fatta di una mescolanza di
vocaboli africani, francesi, inglesi, olandesi, portoghesi, ed anche
alcune parole malgasce che provenivano dalle sei famiglie indigene che
erano entrate a far parte della comunità. Le due corvette, con ufficiali
eletti da equipaggio misto, composto di bianchi e neri in parti uguali,
cominciarono il loro giro d'esplorazione intorno all'isola. Occorsero
quattro mesi per completare il tutto, e il mastro d'istruzione poté
compilare delle carte assai dettagliate. Molti degli ex-schiavi africani
erano divenuti ormai pratici di navigazione. Così, Misson e Tew, con
due navi, andarono bordeggiando lungo la costa araba. Qui, ben presto,
intercettarono un vascello del Gran Mogol, un enorme veliero con
centodieci cannoni e millecinquecento persone a bordo tra marinai e
pellegrini in viaggio verso la Mecca.
A dispetto della stazza, la
nave oppose una debole resistenza, poiché l'equipaggio non poteva
agevolmente manovrare a causa della folla di gente e bagagli che
ingombrava il ponte. I due battelli pirata la affiancarono e si
apprestarono ad arrembarla. I difensori spararono una scarica con armi
di piccolo calibro, senza usare i cannoni, e poi si arresero, senz'altra
resistenza.
Si decise di tenere il vascello e di portarlo a
Libertatia. I cannoni sarebbero stati utili e inoltre si poteva
procedere con maggiore cura alla ricerca degli oggetti preziosi che
spesso gli Indiani nascondevano nelle intercapedini dello scafo e tra la
zavorra. I passeggeri e l'equipaggio furono sbarcati tra Ain e Aden, a
un tiro di schioppo dalla civiltà. Durante lo sbarco dei passeggeri, ci
fu un incidente che, visto a posteriori, può essere interpretato come un
primo sintomo della perdita dell'influenza di Misson sullo sviluppo di
Libertatia come comunità libertaria. L'equipaggio pirata, infatti, volle
tenere con sé un centinaio di ragazze di età tra i dodici e i diciotto
anni, per portarle a Libertatia come "mogli" per i celibi. Misson si
oppose fieramente a ciò, e riunì l'assemblea per discutere il problema,
ma si trovò in minorenza. La nave indiana era un vero e proprio mostro
ligneo, e si rivelò assai lenta e pesante durante la navigazione verso
il Madagascar. In una tempesta, poco mancò che venisse perduta. Una
volta a Libertatia, venne demolita con cura, recuperando tutto "il
sartiame, il legno, le viti, i chiodi, i gangi, lecatene e le altre
attrezzature in ferro". I centodieci cannoni vennero installati in due
batterie, su ciascun lato dell'imboccatura del porto.
A
quell'epoca, i coloni avevano un buon quantitativo di terra coltivata, e
circa trecento bestie comprate dai commercianti indigeni. I docks erano
finiti e la prima nave messa m cantiere fu la Victoire. Essa infatti
era ormai vecchia e inadatta a lunghi viaggi; venne perciò demolita, e
ricostruita con lo stesso nome. La nuova Victoire si preparava a far
vela verso la Guinea, quando una delle corvette entrò nella baia.
L'equipaggio africano era in grande agitazione. Gli uomini dissero che,
mentre erano in viaggio d'addestramento, avevano incrociato cinque
grosse navi che dirigevano verso Libertatia. A giudicare dall'aspetto,
erano vascelli portoghesi, con cinquanta pezzi ciascuno e traboccanti di
uomini armati. Era arrivato il momento dell'inevitabile aggressione.
L'intera colonia di Libertatia corse a posti di combattimento, mentre le
cinque navi puntavano verso il porto, alzando i colori portoghesi. I
due forti non erano efficenti come sperato. I loro cannoni riuscirono ad
aprire una gran falla in una delle imbarcazioni, ma le altre
veleggiarono indenni. Una volta dentro il porto, i portoghesi erano
convinti di aver ormai raggiunto il proprio scopo, e si apprestarono a
calare le scialuppe, piene di uomini armati, per procedere
all'occupazione della colonia. Ma avevano fatto male i conti: una
pioggia di cannonate si abbatté su di loro, da ogni parte. Sparavano
contemporaneamente le batterie a terra, i due forti, le due corvette, la
Victoire e il Bijoux. Due navi colarono a picco, le altre volsero la
prua e cercarono di sottrarsi a quell'inferno. Fortunatamente per loro, i
portoghesi erano arrivati, poco prima del cambio della marea e
"guadagnarono l'uscita assai più rapidamente di quanto non avessero
impiegato per entrare".
Il Bijoux e la Victoire si gettarono
all'inseguimento. La nave fallata rimaneva indietro e fu ben presto
raggiunta dai pirati, mentre gli altri vascelli l'abbandonavano al suo
destino. L'equipaggio si difese fieramente, ma alla fine chiese
quartiere, che venne concesso. Disgraziatamente, tra i prigionieri
portoghesi i pirati scovarono due degli uomini che erano stati, a suo
tempo, rilasciati da Alisson sulla parola che non si sarebbero arruolati
contro

Libertatia.
Costoro ebbero un pubblico processo per "spergiuro e ingratitudine":
Misson e Caraccioli chiesero una punizione corporale, ma Tew insistette
perché fossero impiccati, sostenendo che il delitto di cui si erano
macchiati richiedeva una pena esemplare. Le sue argomentazioni
riuscirono a convincere anche Caraccioli, il quale si rivolse al popolo
di Libertatia, dando atto a Misson della sua generosità nei confronti
dei malfattori ma rilevando, altresì che "non avvi regola che non
ammetta eccezioni". Al termine del discorso, la folla rumoreggiò,
gridando che "l'impiccagione era pena lieve per quei ribaldi". Vennero
appesi ai pennoni dei due forti. Il sogno libertario di Misson
cominciava a svanire. Nel tentativo di dirimere una contesa tra il
proprio equipaggio e quello di Tew, si trovò coinvolto in una sfida a
duello con Tew stesso, che venne evitata in extremis dal conciliatorio
intervento di Caraccioli. Questi suggerì, al fine di impedire che tali
inconvenienti avessero a ripetersi in futuro, che si istituisse un
governo formale, il quale avrebbe provveduto ad emanare "leggi giuste ".
Il giorno dopo, il problema dell'istituzione di un governo venne
sottoposto all'assemblea dell'intera comunità riunita. Johnson descrive
Caraccioli come dotato di "un'argomentazione persuasiva ed insinuante".
Il risultato fu che tutti convenirono sulla necessità di eleggere un
Presidente e un governo, nonché di ripartire in parti uguali tra i
membri di Libertatia il tesoro comune e il bestiame. La terra avrebbe
potuto essere cintata e sarebbe diventata proprietà privata di colui che
la cintava. Fu costruita una Sala del Parlamento, in legno, e la prima
riunione durò ben dieci giorni e promulgò un notevole numero di leggi.
Misson venne eletto Presidente, con diritto al titolo di Suprema
Eccellenza. Tew fu nominato Ammiraglio della Flotta e Caraccioli
Segretario di Stato.
Bestiame e tesoro fuorono divisi. Gli
appezzamenti di terreno vennero cintati. Coloro che recitavano più terra
di quanto fossero in grado di coltivare da soli, ora potevano, e col
beneplacito della legge, assumere altri membri di Libertatia come
lavoranti. Nel giro di un mese dall'attacco portoghese, la "libera
colonia" aveva istituito la pena capitale, la moneta, la proprietà
privata e il lavoro salariato.
Libertatia, comunque, aveva bisogno
di altre braccia per mantenere la propria economia agricola e sopperire
alle necessità della flotta. Sulla costa era ancora in vita la comunità
fondata, come si è visto, dal timoniere di Tew con una ventina di
uomini. Tew decise di recarsi colà in visita, per indurre i partecipanti
ad unirsi a Libertatia. Il parlamento, però, si pronunciò contro un
invito indiscriminato, e, rinnegando le proprie origini in nome della
neo-acquisita rispettabilità, dichiarò che coloro che seguivano il
vecchio timoniere erano "d'indole sediziosa, e avrebbero potuto
contagiare gli altri con uno spirito di disordine". Tew ricevette
istruzioni di accettare soltanto quelli seriamente intenzionati ad
unirsi a Libertatia e per i quali avrebbe potuto garantire, sul suo
onore, che si sarebbero comportati degnamente.Tew salpò con la Victoire,
e dopo qualche giorno di navigazione gettò l'ancora di fronte al luogo
dove si erano stabiliti gli ex-membri della sua durma. Issò un'insegna e
sparò una salva, ma non ottenne risposta. Allora sbarcò,con una
scialuppa, e finalmente incontrò due uomini, che lo condussero al loro
insediamento nei boschi. Tew parlò ai suoi antichi compagni, invitandoli
a tornare con lui a Libertatia e spiegando i vantaggi che avrebbe
portato. Il vecchio timoniere non ebbe difficoltà ad ammettere che la
cosa avrebbe portato grandi vantaggi a Libertatia, ma disse che questi
non lo sarebbero stati altrettanto per sé ed i suoi compagni, dal
momento che "essi godevano colà di tutto quanto abbisognavano per la
loro esistenza, ed erano liberi e indipendenti da chiunque". E aggiunse
significativamente che "sarebbe invero una follia assoggettarsi
nuovamente ad un governo il quale, per quanto mite, esercita pur sempre
un'imperio sui governati". Il gruppo, infatti, si era dato una forma di
governo molto semplice, consistente unicamente in un Governatore che
restava in carica tre mesi ed era scelto a sorte. Il potere di tale
Governatore si limitava ad una funzione di arbitraggio nelle questioni
d'ordinaria amministrazione. La "lotteria" per l'elezione era aperta ad
ogni membro che non avesse ancora avuto la carica: "con un simile
sistema ognuno avrebbe ottenuto, prima o poi, l'opportunità di
esercitare il supremo comando". Ciò, era ritenuto preferibile ad
un'elezione vera e propria, poiché in tal modo "venivano evitati i
problemi delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché l'insorgere di
divisioni e partite tra i membri della colonia, ed era quindi possibile
mantenere tra essi quell'armonia inseparabile dall'unità". Gli
excompagni di Tew, comunque, erano consapevoli della propria posizione
nei confronti del mondo esterno. Non erano una colonia ufficialmente
riconosciuta, e quindi non potevano dedicarsi ad attività commerciali
legali, a causa delle sanzioni che colpivano chi prestava aiuto ai
pirati. Inoltre, appunto perché pirati potevano essere impunemente
aggrediti da ogni vascello militare che si fosse trovato a passare da
quelle parti, qualunque fosse la sua nazionalità, o da qualche nave di
avventurieri. A questo proposito, il timoniere disse che essi erano
disponibili a che qualche rappresentanza inglese, dall'America o
dall'Europa, impiantasse lì una colonia, purificandoli dall'odioso
status di pirati. Ma su ciò non si facevano illusioni. "è buffo, pensare
che finiremo per cacciarci in guai più grandi di noi", concluse il
timoniere.
Tew fece ritorno sulla Víctoire, e il giorno dopo si
recò nuovamente dai suoi antichi compagni portando rum e brandy. Mentre
stavano "facendo fuori" un gamellone di punch, scoppiò improvvisamente
un uragano. Tew segnalò da riva che voleva tornare a bordo, ma il mare
era troppo agitato perché si potesse rischiare di mettere in acqua una
barca. L'uragano aumentò di intensità, colpendo in pieno la Victoire
ancorata al largo. Da terra, Tew e gli altri non poterono far altro che
stare a guardare, impotenti, come la nave cercava di trarsi d'impiccio.
Due ore, durò la lotta disperata contro l'infuriare deli ormeggi, fu
spinta contro gli scogli e colò a picco con tutto l'equipaggio.
Tew
non poteva più tornare a Libertatia, ora, e fu costretto ad accettare
l'ospitalità dei suoi ex-marinai. Di lì a tre mesi, venne avvistata al
largo una grossa imbarcazione che sembrava il Bijoux, ma questa ignorò i
fuochi accesi in segnalazione e proseguì per la sua strada. Un mese più
tardi, giunto di buon'ora sulla spiaggia, Tew trovò due corvette
ancorate a breve distanza del litorale: erano la Gioventù e la Libertà.
Venne a riva una scialuppa. A bordo c'era Misson, e la gioia del
ritrovamento fu rapidamente cancellata dalle notizie che questi recava.
In piena notte, senza la minima provocazione, due folti drappelli di
indigeni avevano attaccato Libertatia, sguarnita di uomini poiché sia la
Victoire, che il Bijoux erano per mare. Caraccioli aveva radunato i
pochi rimasti per una estrema resistenza, ma era stato massacrato. Gli
indigeni avevano invaso la città uccidendo tutti quelli che
incontravano, uomini, donne o bambini che fossero. Misson, con
quarantasei scampati, e quel poco che avevano potuto portare con sé, era
riuscito a raggiungere le due corvette e prendere il largo. Libertatia
era perduta. Tew suggerì di far vela per l'America, dove Misson non era
conosciuto e poteva ricostruirsi un'esistenza pacifica, e l'idea piacque
al timoniere, che sperava di poter ottenere in quel modo una
concessione per la fondazione di una colonia ufficialmente riconosciuta.
Ma Misson, dopo il fallimento di Libertatia, aveva perso ogni
entusiasmo. Così, decise di tornare in Europa per visitare in segreto la
sua famiglia e ritirarsi dal mondo. Quanto restava del suo sogno di
libertà, tesoro e uomini, venne diviso tra le due corvette. I più
scelsero di stare con Tew.
I pirati attesero una settimana, nella
speranza che il Bijoux tornasse, ma inutilmente. Allora partirono verso
la costa della Guinea, dove forse anche il Bijoux si era diretto e
avrebbero potuto incontrarlo. Durante il viaggio, le due navi furono
sorprese da un uragano: l'imbarcazione di Misson naufragò e colò a
picco, senza che gli altri potessero fare alcunché per aiutarla. Non ci
furono superstiti. Tew fece rotta per l'isola di Santa Maria, al largo
della costa malgascia, dove l'ex-pirata Adam Baldridge aveva impiantato
un centro commerciale. Al riparo del forte di Baldridge, la corvetta
(iscritta col nome di Amity, il vecchio nome dell'imbarcazione di Tew)
venne carenata e preparata per una traversata atlantica. Secondo i
registri di Baldridge, l'Amity lasciò Santa Maria nel dicembre 1693.
Arrivò all'isola di Rodi nell'aprile 1694.
Tew se ne stette
tranquillo per parecchi anni, ma i suoi vecchi compagni continuavano ad
assillarlo, proponendogli di fare un ultimo viaggio. Alla fine non seppe
resistere, comprò una piccola corvetta e riprese il mare. Durante una
battaglia contro una nave del Gran Mogol, nel Mar Rosso, fu colpito in
pieno da una palla di cannone e morì di lì a poco.
(Traduzione di Gisetta De Amici)
Tratto da
Volontà n. 2 del 1986
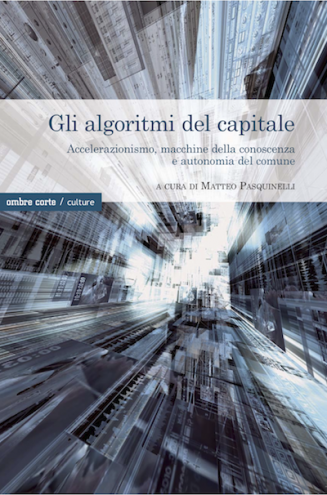

 Il
capitano Misson trascorse la maggior parte della propria vita da adulto
come pirata. Ma il suo vascello, che solcava i mari battendo una
bandiera con il motto "Libertà", non era l'unico, tra la fine del 17°
secolo e l'inizio del 18°'. Le navi pirate di quel tempo erano quasi
tutte,vere e proprie repubbliche galleggianti. A bordo, le decisioni
venivano prese dall'equipaggio riunito in assemblea, o da un comitato di
delegati. Alcune navi pirata dei Caraibi si diedero persino dettagliate
costituzioni. Diversamente dai personaggi autoritari di cui si legge
nei racconti di avventure, i veri capi pirata avevano il diritto di
comando solo durante il combattiemento con le navi avversarie; nelle
altre occasioni, era il timoniere a svolgere il ruolo di leader della
cominità, fungendo da arbitro in caso di conflitto tra i mebri
del'equipaggio. Il bottino preso sulle navi catturate veniva diviso in
modo egualitario. Al capitano, di solito, toccava una parte doppia, per
aver fisicamente guidato l'attacco, e in certi casi una volta mezza, o
una volta e un quarto, andava al timoniere, al capo cannoniere e al
carpentiere. Quote fisse venivano anche pagate come indennizzo per le
ferite riportate in battaglia. I capitani spietati e dittatoriali, a
quel tempo, non stavano sulle navi pirate, ma sui vascelli mercantili o
militari. La vita dei marisi "normali" era dura e pericolosa, e la paga
scarsa. Gli ufficilai potevano comminare punizioni che includevano la
catena, la frusta, e il "giro di chiglia": quest'ultima consisteva nel
gettare in mare la vittima, legata a una gomena, e farla passare più
volte (a seconda della gravità del "reato" commesso, sotto lo scafo
della nave. Era una pena che spesso risultava fatale. Il fatto che
presso i pirati non esistesse la ferrea disciplina che regnava sulle
altre navi, viene spesso addotto come una delle cause della loro
sconfitta. Ma questa è una strana asserzione, poiché i pirati
effettivamente sconfitti furono assai pochi: sulle rotte delle Indie
orientali, le probabilità di cattura erano meno dell'uno per cento, e su
quelle delle Indie occidentali erano praticamente nulle.
Il
capitano Misson trascorse la maggior parte della propria vita da adulto
come pirata. Ma il suo vascello, che solcava i mari battendo una
bandiera con il motto "Libertà", non era l'unico, tra la fine del 17°
secolo e l'inizio del 18°'. Le navi pirate di quel tempo erano quasi
tutte,vere e proprie repubbliche galleggianti. A bordo, le decisioni
venivano prese dall'equipaggio riunito in assemblea, o da un comitato di
delegati. Alcune navi pirata dei Caraibi si diedero persino dettagliate
costituzioni. Diversamente dai personaggi autoritari di cui si legge
nei racconti di avventure, i veri capi pirata avevano il diritto di
comando solo durante il combattiemento con le navi avversarie; nelle
altre occasioni, era il timoniere a svolgere il ruolo di leader della
cominità, fungendo da arbitro in caso di conflitto tra i mebri
del'equipaggio. Il bottino preso sulle navi catturate veniva diviso in
modo egualitario. Al capitano, di solito, toccava una parte doppia, per
aver fisicamente guidato l'attacco, e in certi casi una volta mezza, o
una volta e un quarto, andava al timoniere, al capo cannoniere e al
carpentiere. Quote fisse venivano anche pagate come indennizzo per le
ferite riportate in battaglia. I capitani spietati e dittatoriali, a
quel tempo, non stavano sulle navi pirate, ma sui vascelli mercantili o
militari. La vita dei marisi "normali" era dura e pericolosa, e la paga
scarsa. Gli ufficilai potevano comminare punizioni che includevano la
catena, la frusta, e il "giro di chiglia": quest'ultima consisteva nel
gettare in mare la vittima, legata a una gomena, e farla passare più
volte (a seconda della gravità del "reato" commesso, sotto lo scafo
della nave. Era una pena che spesso risultava fatale. Il fatto che
presso i pirati non esistesse la ferrea disciplina che regnava sulle
altre navi, viene spesso addotto come una delle cause della loro
sconfitta. Ma questa è una strana asserzione, poiché i pirati
effettivamente sconfitti furono assai pochi: sulle rotte delle Indie
orientali, le probabilità di cattura erano meno dell'uno per cento, e su
quelle delle Indie occidentali erano praticamente nulle. Dopo
alcune avventure di minor conto, tra cui il tentativo, fallito, di una
nave corsara di prendere la Victoire, i pirati della libertà riuscirono a
catturare un vascello olandese. Giunti a Cartagena, Misson e Caraccioli
si travestirono da ufficiali della marina francese, presentandosi come
Fourbin e il suo primo ufficiale, e poterono vendere il bottino e
sbarcare i prigionieri. Il governatore, tal Don Giovanni de La Zerda,
restò così favorevolmente impressionato dai due, che, conclusi gli
affari, chiese loro un piccolo favore: avrebbe gradito che la Victoire
si recasse a Porto Bello per scortare il St. Joseph, un galeone da
settanta cannoni, lì ancorato. L'ingenuo funzionario era preoccupato per
l'incolumita' del suo carico, che consisteva in 800.000 pezzi da otto e
un cospicuo quantitativo di oro in lingotti.
Dopo
alcune avventure di minor conto, tra cui il tentativo, fallito, di una
nave corsara di prendere la Victoire, i pirati della libertà riuscirono a
catturare un vascello olandese. Giunti a Cartagena, Misson e Caraccioli
si travestirono da ufficiali della marina francese, presentandosi come
Fourbin e il suo primo ufficiale, e poterono vendere il bottino e
sbarcare i prigionieri. Il governatore, tal Don Giovanni de La Zerda,
restò così favorevolmente impressionato dai due, che, conclusi gli
affari, chiese loro un piccolo favore: avrebbe gradito che la Victoire
si recasse a Porto Bello per scortare il St. Joseph, un galeone da
settanta cannoni, lì ancorato. L'ingenuo funzionario era preoccupato per
l'incolumita' del suo carico, che consisteva in 800.000 pezzi da otto e
un cospicuo quantitativo di oro in lingotti.  Ritornato
a Johanna, Misson espose il suo piano agli equipaggi delle due navi e
ottenne la loro approvazione. Inoltre, la regina dell'isola, in cambio
della promessa di venire in soccorso a Johanna in caso di attacco, gli
offrì trecento uomini per aiutarlo a costruire la nuova base. L'unica
condizione posta era che gli uomini tornassero a Johanna entro quattro
mesi. l pirati chiamarono la loro nuova patria Libertatia, e a se stessi
diedero l'appellativo di Liberi, rinunciando a definirsi Inglesi,
Francesi, Olandesi o Africani. Per prima cosa, costruirono due forti,
uno per ogni lato dei porto. Questi erano armati con quaranta cannoni,
presi alla nave portoghese. Poi si diedero a costruire case e magazzini.
Un gruppo andò in missione nell'interno, per stringere rapporti
amichevoli con i nativi e scambiare doni. Quando i lavori erano ormai
avviati, Misson spinse la Victoire fino alla costa di Zanzibar e
intercettò un'altra nave portoghese che portava un carico d'oro. La
Victoire viaggiava con armamento ed equipaggio ridotti, cosicché Misson,
comprendendo di aver addentato un boccone troppo grosso, tentò di
sganciarsi. Ma il vascello portoghese insegui la Victoire e attaccò
battaglia. Lo scontro durò quattro ore: alla fine, i pirati riuscirono
ad abbordare la nave e a prenderla. I marinai portoghesi vennero
rinchiusi sottocoperta e, con l' indispensabile di equipaggio, la preda
seguì la Victoire a Libertatia. In vista del Madagascar, incrociarono
una corvetta che inalberava una bandiera nera su cui era dipinto, in
bianco, un braccio che brandiva una scimitarra. Era il veliero del
pirata Thomas Tew. Le due navi si affiancarono, e i francesi si recarono
in visita a conoscere i "colleghi" americani. Dopo qualche discussione,
Tew e i suoi uomini decisero di accompagnare la Victoire a Libertatia.
Ritornato
a Johanna, Misson espose il suo piano agli equipaggi delle due navi e
ottenne la loro approvazione. Inoltre, la regina dell'isola, in cambio
della promessa di venire in soccorso a Johanna in caso di attacco, gli
offrì trecento uomini per aiutarlo a costruire la nuova base. L'unica
condizione posta era che gli uomini tornassero a Johanna entro quattro
mesi. l pirati chiamarono la loro nuova patria Libertatia, e a se stessi
diedero l'appellativo di Liberi, rinunciando a definirsi Inglesi,
Francesi, Olandesi o Africani. Per prima cosa, costruirono due forti,
uno per ogni lato dei porto. Questi erano armati con quaranta cannoni,
presi alla nave portoghese. Poi si diedero a costruire case e magazzini.
Un gruppo andò in missione nell'interno, per stringere rapporti
amichevoli con i nativi e scambiare doni. Quando i lavori erano ormai
avviati, Misson spinse la Victoire fino alla costa di Zanzibar e
intercettò un'altra nave portoghese che portava un carico d'oro. La
Victoire viaggiava con armamento ed equipaggio ridotti, cosicché Misson,
comprendendo di aver addentato un boccone troppo grosso, tentò di
sganciarsi. Ma il vascello portoghese insegui la Victoire e attaccò
battaglia. Lo scontro durò quattro ore: alla fine, i pirati riuscirono
ad abbordare la nave e a prenderla. I marinai portoghesi vennero
rinchiusi sottocoperta e, con l' indispensabile di equipaggio, la preda
seguì la Victoire a Libertatia. In vista del Madagascar, incrociarono
una corvetta che inalberava una bandiera nera su cui era dipinto, in
bianco, un braccio che brandiva una scimitarra. Era il veliero del
pirata Thomas Tew. Le due navi si affiancarono, e i francesi si recarono
in visita a conoscere i "colleghi" americani. Dopo qualche discussione,
Tew e i suoi uomini decisero di accompagnare la Victoire a Libertatia. Libertatia.
Costoro ebbero un pubblico processo per "spergiuro e ingratitudine":
Misson e Caraccioli chiesero una punizione corporale, ma Tew insistette
perché fossero impiccati, sostenendo che il delitto di cui si erano
macchiati richiedeva una pena esemplare. Le sue argomentazioni
riuscirono a convincere anche Caraccioli, il quale si rivolse al popolo
di Libertatia, dando atto a Misson della sua generosità nei confronti
dei malfattori ma rilevando, altresì che "non avvi regola che non
ammetta eccezioni". Al termine del discorso, la folla rumoreggiò,
gridando che "l'impiccagione era pena lieve per quei ribaldi". Vennero
appesi ai pennoni dei due forti. Il sogno libertario di Misson
cominciava a svanire. Nel tentativo di dirimere una contesa tra il
proprio equipaggio e quello di Tew, si trovò coinvolto in una sfida a
duello con Tew stesso, che venne evitata in extremis dal conciliatorio
intervento di Caraccioli. Questi suggerì, al fine di impedire che tali
inconvenienti avessero a ripetersi in futuro, che si istituisse un
governo formale, il quale avrebbe provveduto ad emanare "leggi giuste ".
Il giorno dopo, il problema dell'istituzione di un governo venne
sottoposto all'assemblea dell'intera comunità riunita. Johnson descrive
Caraccioli come dotato di "un'argomentazione persuasiva ed insinuante".
Il risultato fu che tutti convenirono sulla necessità di eleggere un
Presidente e un governo, nonché di ripartire in parti uguali tra i
membri di Libertatia il tesoro comune e il bestiame. La terra avrebbe
potuto essere cintata e sarebbe diventata proprietà privata di colui che
la cintava. Fu costruita una Sala del Parlamento, in legno, e la prima
riunione durò ben dieci giorni e promulgò un notevole numero di leggi.
Misson venne eletto Presidente, con diritto al titolo di Suprema
Eccellenza. Tew fu nominato Ammiraglio della Flotta e Caraccioli
Segretario di Stato.
Libertatia.
Costoro ebbero un pubblico processo per "spergiuro e ingratitudine":
Misson e Caraccioli chiesero una punizione corporale, ma Tew insistette
perché fossero impiccati, sostenendo che il delitto di cui si erano
macchiati richiedeva una pena esemplare. Le sue argomentazioni
riuscirono a convincere anche Caraccioli, il quale si rivolse al popolo
di Libertatia, dando atto a Misson della sua generosità nei confronti
dei malfattori ma rilevando, altresì che "non avvi regola che non
ammetta eccezioni". Al termine del discorso, la folla rumoreggiò,
gridando che "l'impiccagione era pena lieve per quei ribaldi". Vennero
appesi ai pennoni dei due forti. Il sogno libertario di Misson
cominciava a svanire. Nel tentativo di dirimere una contesa tra il
proprio equipaggio e quello di Tew, si trovò coinvolto in una sfida a
duello con Tew stesso, che venne evitata in extremis dal conciliatorio
intervento di Caraccioli. Questi suggerì, al fine di impedire che tali
inconvenienti avessero a ripetersi in futuro, che si istituisse un
governo formale, il quale avrebbe provveduto ad emanare "leggi giuste ".
Il giorno dopo, il problema dell'istituzione di un governo venne
sottoposto all'assemblea dell'intera comunità riunita. Johnson descrive
Caraccioli come dotato di "un'argomentazione persuasiva ed insinuante".
Il risultato fu che tutti convenirono sulla necessità di eleggere un
Presidente e un governo, nonché di ripartire in parti uguali tra i
membri di Libertatia il tesoro comune e il bestiame. La terra avrebbe
potuto essere cintata e sarebbe diventata proprietà privata di colui che
la cintava. Fu costruita una Sala del Parlamento, in legno, e la prima
riunione durò ben dieci giorni e promulgò un notevole numero di leggi.
Misson venne eletto Presidente, con diritto al titolo di Suprema
Eccellenza. Tew fu nominato Ammiraglio della Flotta e Caraccioli
Segretario di Stato.